
Morozov, in un suo pezzo sull’inserto domenicale del Corriere, ci ha reso edotti sulle sorti ultime del telelavoro. Questo osservatore che già ci ha compiaciuto con le sue moralistiche analisi di facebook, ora ci propone una sua lettura del magro destino delle utopie hi-tech.
In sintesi, secondo la sua ricerca, il telelavoro non produce né benessere né aumentata produttività, né irenici scenari di integrazione dell’esperienza umana. Ad onta delle più rosee profezie emancipatorie, il telelavoro non va. Questa è la sconsolata considerazione di Morozov, che non appare tuttavia aver militato tra i profeti della causa, almeno dai toni.
E tuttavia aver anche solo potuto pensare che il telelavoro potesse essere una soluzione raccomandabile allo sfruttamento e all’alienazione appare un po’ ingenuo.
Nessuna utopia può verificarsi dove regna la parola lavoro, tele o meno che sia. Il lavoro è in sé e per sé, a meno che non sia opera di pura creatività individuale (ma oggi nemmeno più quello e comunque in tal caso si chiama arte), una delle forme attraverso cui patiamo l’alienazione nel nostro mondo. Sarebbe curioso che il fatto di portarselo a casa trasformasse improvvisamente le cose. Piuttosto probabilmente rischierebbe di trasformare la casa. In che cosa? In un’azienda. Ecco allora che non stupisce che ci si sfrutti da sé, in casa, come sottolinea il nostro a proposito dei risultati di alcune ricerche svolte sul “campo” domestico. Inoltre lavorare a casa, lavorare insisto, sarebbe un regalo a uno degli obiettivi che da sempre gli "imprenditori" perseguono: parcellizzare il lavoro, isolare i lavoratori, inscrivere la norma dentro la loro anima, opera su cui i fautori della qualità totale si sono infaticabilmente adoprati per altre vie. Se le imprese si sono sempre avvalse, e continuano a farlo, di competenze distribuite nelle famiglie (si pensi a quanto mercato fa profitti su lavoro eseguito a livello domestico o in magazzini e sottoscala, senza diritti e in pura legge di sfruttamento), è anche per evitare che i lavoratori si potessero confrontare e organizzare (oltre che per sommergere quelle parti di lavoro che, una volta emerse, avrebbero gravato significativamente sui costi).
La parcellizzazione ad alto tasso professionale non riesce a mascherare il suo profilo da alienazione atomizzata e diffusa, seppure magari dorata e obesa. Senza contare che chi lavora nel nostro contesto industriale non può non avere introiettato la norma del lavoro contemporaneo, che è la produttività massimizzata. Lavorare sotto la pressione di una produttività di tal specie non può che snaturare qualsiasi utopia di lavoro liberato e felicemente traslocato tra le pareti domestiche.
L’utopia sta ben altrove dal telelavoro. Fa bene Morozov a sottolineare che le tecnologie non vanno certo nella direzione della liberazione e della conciliazione tra vita e lavoro. Questo lo dice in toni un po’ più brillanti e radicali per esempio anche Philippe Godard: “una macchina non ha altra funzione se non lavorare sempre, ininterrottamente, come un rullo compressore. Come un rullo oppressore”.
La liberazione del lavoro, quella onestamente radicale, se non utopica, nel miglior senso del termine (quello di Fourier, per quanto mi riguarda), si chiama liberazione dal lavoro, all’indirizzo di una vita semplicemente più umana, più incline a sintonizzarsi sui ritmi della natura (ahi, snaturata natura naturata), più intermittente, capace di inscrivere al suo interno soste, vuoti, momenti di puro dispendio. Contrassegnata da nuove forme di operatività. Operatività per definire la quale il termine lavoro sarebbe finalmente improprio e sconveniente. Un’operatività capace di rallentare, di dilatare, di intensificare l’esperienza di vite, le nostre, quelle di tutti noi, che, lavorando a casa o in azienda o in qualsiasi altro posto, restano ahinoi orribilmente deprivate.
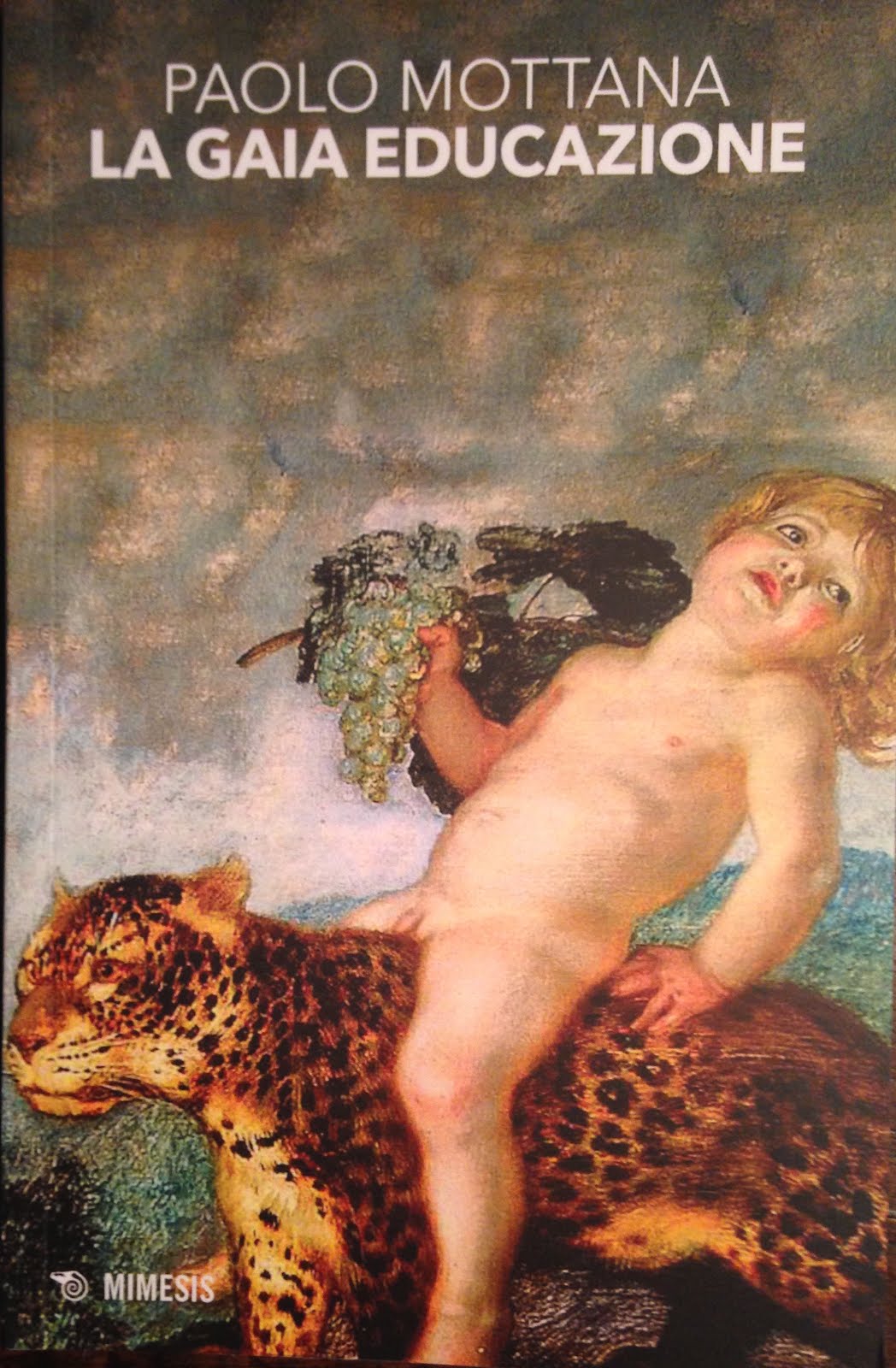

Nessun commento:
Posta un commento