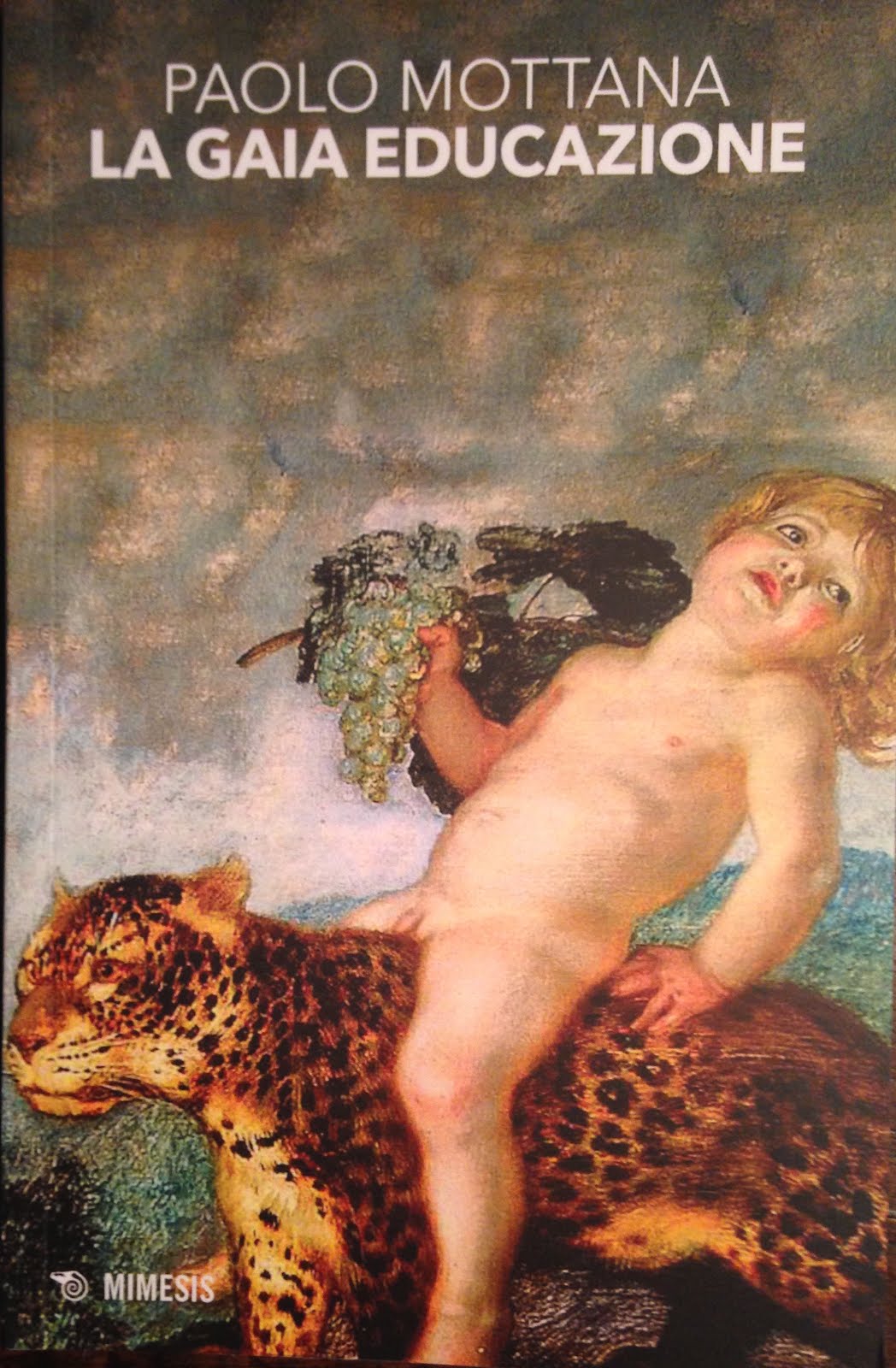A volte mi chiedo se non lavoro per il disadattamento. Può apparire una domanda futile ma io me la pongo. E, più o meno direttamente, me la pongono anche altri. Futile perché è difficile sottrarsi a quello che si è o forse anche perché è così difficile definire cosa sia disadattamento.
Veniamo ad verba, e alla parola sotto processo. Disadattato: sul mio vecchio Zanichelli neppure compare, surrogata dalla voce disadatto, che però non ci serve a nulla (se non a denotare la zona semantica). Vediamo: sull’Hoepli online troviamo, con una bella sigla PSIC.: “chi è caratterizzato da incapacità di affrontare in modo adeguato i problemi posti dall'ambiente in cui vive”. Il che, si presume, ne fa immediatamente un disgraziato, o simile.
Si deve dire dunque che il disadattato adotta soluzioni ai problemi inadeguate e dunque fallimentari per il suo ambiente. Qui si aprirebbero molte interessanti questioni. Anzitutto quella che vede il disadattato potenzialmente adattato a un ambiente diverso dal suo. E’ un’ipotesi che forse proverò a seguire. Ma poi che si tratta di individuare soluzioni a problemi che non vengono dichiarati se non, un po’ genericamente, come problemi postigli dall’ambiente. Tutti?
Certo così il disadattato sembra proprio nei guai, perché se non è in grado, perlomeno in maniera adeguata, di risolvere alcun problema che gli pone l’ambiente, allora vuol dire che è nel disastro. Per esempio dovremmo presumere che non sappia alimentarsi, proteggersi dagli elementi o persino reclamare per sé uno spazio di vivibilità fisica, almeno adeguatamente.
Il disadattato precipiterebbe così nella categoria dell’inabile (ben più radicale di disabile), o del derelitto, almeno sul piano materiale.
In verità io penso ad altro disadattamento, quello che mi affligge personalmente del resto, che si voglia chiamarlo diversamente o più eufemisticamente. Diciamo per brevità che penso a quel tipo di disadattamento o inadattabilità o controadattamento che è appunto l’atteggiamento ribelle, insofferente della norma, dello statu quo. In maniera strutturale. E che proprio in questo senso può anche essere compreso come una sorta di malattia, di deformazione. Questa irresistibile coazione a differenziarsi, a immaginare la vita altrove e mai qui, insomma.
Ecco, la mia attività, i miei libri, il mio “impegno” non sono forse orientati a stimolare quella parte che in ognuno di noi si smarca dalla norma e ci conduce a divenire contro? E in ciò peraltro a diventare inevitabilmente disadattati, infelici, irrequieti, arrabbiati e talora persino disperati, come spesso mi sento io ultimamente (checché si dica e sia stato detto sulla vitalità della ribellione)?
Diceva, come è noto, Thoreau, c’è chi vive “vite di quieta disperazione”. Ahi, davvero? Disperazione? Io vedo persone intorno a me che si accomodano alle regole del gioco e vivono vite tutt’altro che disperate, non so quanto quiete ma certamente convenienti e anche remuneranti dacché si mostrano compiacenti. Chi acconsente allo statu quo è molto più probabile che si danni meno e che addirittura ottenga molto. Le parabole di coloro che hanno saputo rinunciare ai loro spigoli per essere meglio accolti, in ogni campo del vivere sociale, ci raccontano questo. Vivi e lascia vivere. Accetta il codice dominante e otterrai infinite prebende.
Sempre questo codice ha regolato le vite verso la soddisfazione. Può anche darsi che passino poi alla storia gli altri, i sofferenti, gli incompresi, gli inattuali. Ma guardiamoli, osserviamo quanta disperazione, quanto sacrificio, quanta amarezza gli sono costati in vita!
Io amo Nietzsche, amo Van Gogh, amo Artaud, ma la loro divergenza, la loro insofferenza, la loro impossibilità ad adattarsi non gli sono costati terribilmente cari? Certo, hanno lasciato opere incomparabili (per noi disadattati) ma per loro?
Giustamente si potrà dire che non potevano essere diversamente. Che la loro biografia incarna una vocazione, una necessità, un carattere appunto, se non una biologia, alla quale non potevano sfuggire. E sia. Ma ci è dato il lusso di non essere consapevoli della deriva che il propagare simili esempi porta con sé?
Non lo so più. Sono domande futili, perché appunto non si può che essere quello che si è. Ma in fin dei conti ciascuno di noi è davvero ciò che è o è piuttosto quel qualcosa che in lui si dibatte per affermare la sua sporgenza proprio oltre quella norma che lo annegherebbe sì nell’anonimato ma forse gli garantirebbe la quiete e qualche soddisfazione?
Essere qui e ora. Un dilemma, dal momento che non lo sappiamo mai dove siamo veramente. Io sono davvero un ribelle o è l’unica maschera che so indossare? Se fosse così, e dunque potessi pensare che chi seguirà le mie idee sarà anche lui uno con una sola maschera, sarebbe consolante. Non sarà mio demerito. Gli sarebbe comunque accaduto, prima o poi. Una lezione vale un’altra per chi è vocato alla deviazione e all’infelicità.
Ok, sì, tutto questo sa di sproloquio e di autoflagellazione. Ma di questi tempi va così. Oppure è sempre andato così. Il dubbio è che un infelice (io) cerchi di contagiare anche chi non lo è con la sua infelicità e la sua impossibilità a essere felice.
Ma forse, per ribadire il concetto sopra espresso, sarà comunque un destinato all’infelicità, ad allearsi con lui. Sempre che adattamento e felicità, come dicono gli psicologi, siano una sorta di endiade come ahimé appare sempre più chiaramente anche a un irriducibile ribelle infelice (ma forse sarebbe giusto invertire e dire infelice e ribelle) come me.
Consola sapere (si apprezzi l’ironìa) che son ben pochi quelli che ascoltano i miei pensieri. Io stesso uno dei pochi che ha ascoltato i pensieri di altri ribelli infelici. Pubblico scarso, danno limitato.